Francesco Carbone: insegnamento vivo
di Tommaso Romano
Per l’occasione della prima edizione
del Premio Francesco Carbone – Experimenta, presieduto da Aldo Gerbino e che si
svolge alla Reggia-casina di caccia di Ficuzza domenica 24 Settembre 2017 alle
ore 16:00, ripubblichiamo un testo di Tommaso Romano (che è fra i premiati di
questo prestigioso Premio, organizzato dall’Istituzione Culturale Francesco
Carbone, egregiamente presieduta da Vincenzo Viscardi, con la supervisione
della Galleria Studio 71 ben diretta da Francesco M. Scorsone) tratto da Ammirate biografie. Incontri e profili di
siciliani e non, con nota introduttiva di Anna Maria Ruta, edito da Arianna
(Geraci Siculo) nel 2010. In seguito pubblicheremo integralmente il n. 92 della
rivista “Spiritualità & Letteratura” dedicato integralmente a Carbone.
Dobbiamo
all’azione congiunta e alla volontà di Nicolò D’Alessandro e di Nicola Bravo
(attento e generoso operatore culturale e d’arte con l’Associazione e Galleria L’Altro - Artecontemporanea di Palermo) e anche, se è lecito,
al sottoscritto per la parte realizzativa, la pubblicazione del volume - curato
impeccabilmente da D’Alessandro - Francesco Carbone. Antologia di saggi
critici e altre occasioni 1960/1990, ospitato al numero 28 della Collana Ercta della
Provincia Regionale di Palermo (2007), che dirigevo con Francesco Musotto e che
ho fondato.
Questo
libro è un omaggio doveroso, non di maniera e meno che mai encomiastico in
senso nostalgico, a Francesco Carbone, (Cirene di Libia, 1923-Palermo 24
dicembre 1999).
Ma
è anche un volume di bella mole (360 pagine fitte) che raccoglie molti
interventi critici - specie d’arte e letteratura e alcuni teorici - di Carbone,
assemblati con impegno storico-documentario e intelletto d’amore da D’Alessandro,
autentico e geniale continuatore, erede ideale di Carbone, che egli conobbe nel
1963 al Circolo Rinascita di Agrigento e di cui divenne
fervido e convinto sodale, artefici - tutti e due - della riconsiderazione
umana e critica di un grande poeta del Futurismo “agreste” siciliano, Giacomo
Giardina. Carbone, su invito dell’ISSPE, proprio su Giardina, tenne una
memorabile relazione al Convegno Il
Futurismo, la Sicilia
del 1996 ora edita nell’omonimo volume, che ho curato con Umberto Balistreri,
l’anno dopo.
Leggendo
e studiando questa densa Antologia si avverte la convergente intesa fra
Francesco e Nicolò, esempio di un binomio d’amicizia e d’arte di altissimo
significato e valore.
Curioso
è il fatto che ambedue siano siciliani nati in Libia.
Disegnatore
straordinariamente efficace, personalissimo e inconfondibile nel segno,
D'Alessandro autore del lungo disegno “La Valle dell'Apocalisse” di oltre 83
metri, è operatore culturale e sociale, insegnante, narratore di simboli e
parole, analista sagace, fautore di completi volumi storico-critici relativi
alla situazione e alle prospettive dell’arte in Sicilia. D’Alessandro ha
scritto il saggio introduttivo al volume in questione, organico ed esaustivo,
introducendo così il “percorso astorico” delle “occasioni critiche” di Carbone
donate con generosità a molti artisti, ma anche riproducenti sempre le idee, le
costanti, il furore e la febbre (per dirla con Zagarrio) di una scrittura
pensante e proponente, orma non violenta (al pari di quella di Danilo Dolci) di
questo personaggio anomalo, senza velleità accademiche, che ha lasciato nella
radicalità ideativa una pratica d’arte intesa come passione e renovatio della vita.
Carbone
è, infatti, paragonabile, nel suo magistero artistico ed umano, solo a se
stesso. Per l’ampiezza degli interessi e delle curiosità critiche è, invece,
accostabile solo a Maria Accascina. Se si leggono di questa gli interventi sul
primo Novecento artistico e di Carbone quelli sul secondo Novecento in Sicilia,
si avrà un repertorio ampio e assolutamente rigoroso e documentato di tutto un
secolo.
Pittore
sperimentatore in proprio, Carbone fu antropologo e storico a suo modo, sapendo
unire, specie con l’impresa ciclopica e d’autore della Casa Museo-Biblioteca di
Godranopoli, passione, rigore e libertà come dovrebbe sempre essere la
militanza culturale, che spesso si piange addosso, piuttosto che incidere e
produrre degnamente aspettando soltanto benefici e prebende dal potere pubblico
quasi come un dovere e non si capisce il perché.
Così
fu tutta intera l’esistenza di Carbone.
Oltre
a indubbie intuizioni e pratiche letterarie e d’arte nonché giornalistiche che
iniziò a Buenos Aires e continuò fra le colonne della prestigiosa «Fiera
Letteraria», i cui articoli vanno sicuramente ristampati, il nostro è stato un
profeta e un teorico di ciò che è avanti e oltre, nell’arte di “pratiche
sparse”. Lettore delle cose e degli uomini del suo tempo, del sociale inteso
come comunità aperta al futuro contro l’isolamento dell’uomo e cosciente del
suo passato, specie del patrimonio morale del mondo contadino e pastorale. Fu
anche fondatore di diversi musei nella provincia palermitana di
etnoantropologia, proprio rispondendo concretamente alla riscoperta non solo folklorica del territorio. Sono su questa
linea le fondazioni, le gallerie, i gruppi, le riviste create da Carbone, che
D’Alessandro puntualmente narra come avventura intellettuale e, dice, come
specchio di un concezione che insieme è etica ed estetica, unicum riassumibile in un metodo comportamentale.
Vanno
allora citate le direzioni e animazioni di gallerie importanti della nuova
tendenza d’arte visiva a cominciare dalla galleria Il Chiodo di Ciro Li Vigni e Filippo Panseca
e poi alla Ricasolina, a Tempo Sud e all’azione critica ed estetica
attorno alla Libreria Nuova Presenza (diretta da Bartolomeo Manno, che è
pittore assai originale, unitamente al raffinato libraio Piero Onorato) alla
Comunità di Base Roccabusamhra, ai fogli Presenza
Sud (1968), al movimento del Riciclaggio, con il fedele amico e singolare
artista Giusto Sucato a Misilmeri, a Marineo con
Ciro Spataro.
Mediatore
di linguaggi, come lo definisce giustamente D’Alessandro, Carbone fu uomo di
ponti e di libertà. Ho trovato un suo testo nella rivista trapanese «Libeccio»
di Dino Grammatico dell’aprile 1962 e uno su Giacomo Giacomazzi nella moderna
storiografia siciliana
a testimonianza - se ve ne fosse bisogno - della libertà di ricerca ma anche di
incontri e rapporti con apparentemente distanti protagonisti e interpreti di
cultura.
Non
dimentico certo - senza citazioni sterili - il credito che mi diede sempre, pur
governando dal 1994 alla Provincia di Palermo, in una parte politica opposta
alla sua; non mancò di essere sempre presente tutte le volte che lo invitavo
con la capacità e ferma riflessione libera e problematica che
contraddistingueva i suoi ragionamenti e una buona dose di ironia che pure ben
possedeva, unitamente al distillato dei suoi consigli che non dimentico.
Carbone
è stato in quaranta e più anni di magistero socratico, il perno del
rinnovamento contro l’immobilismo, come ha notato acutamente Sergio Troisi.
Sostenitore
di una cultura aperta e a tutti non appannaggio di élites chiuse, non un lamento del sud, né
un fatalistico e incapacitante
chiudersi critico
così, come al contrario notava nell’immortale romanzo di Tomasi di Lampedusa,
tanto da fargli affermare di avere «un fatto personale fra noi e il
Gattopardo».
Possiamo
dire che le sue teorie dell’arte spaziano da lezioni apprese da autori che
vanno da Marx a Eliot (che spesso citava, ammirandolo), pensando all’arte come
mobilità del mondo, e comprendendo e sviluppando il pensiero di Claude Lévi
Strauss, Mac Luhan, Jonesco, Marcuse, Braudel, Munari e la ricerca segnica e
grafica.
Uomo
schierato contro tutte le mafie, auspicò la funzione vivificante della cultura.
Diceva:
«Sarebbe necessario che la politica fosse essa stessa cultura e non una facoltà
o attribuzione rimessa al potere per l’attuazione di una generica politica
culturale».
Se
le “libere scritture visuali” e gli “assemblaggi materici” furono le ultime
sue esperienze teoretiche e concrete, fu sempre l’impegno al centro del suo
messaggio laborioso: «conta l’impegno - diceva - la consapevolezza di volersi
determinare e collocare, in uno spazio di valori totali e non ai margini del
proprio tempo».
L’impresa
di una vita intera spesa per la causa della cultura stava simbolicamente per
concludersi proprio allo scadere del secolo Ventesimo.
Tornano
alla mente, allora, due scritti di Carbone emblematici per questa breve testimonianza.
Il primo dell’aprile 1963 che cosi recitava: «Io sono dentro i miei limiti di
espressione, come contenuto nelle dimensioni di una vicenda comune che potrebbe
concludersi senza l’apporto di qualche traccia esteriore capace di durare.
Sia
in arte che in letteratura, forse non è sempre e soltanto il risultato
raggiunto ciò che conta in ultima analisi».
Il
secondo scritto è del 1998, un anno prima della morte ed è uno stupendo
documento autobiografico a futura memoria morale, una lettera a se stesso, che
vale molte più parole di quelle che si potrebbero dire ancora.
Eccone
il testo: «Non avrei mai sospettato o immaginato che un giorno avrei dovuto
scrivere una lettera a me stesso, né in quale occasione ciò sarebbe accaduto.
Ora lo so (infatti la sto scrivendo), ed è una circostanza certamente insolita,
particolare: quella che tra qualche mese mi vedrà come soggetto, protagonista
di un evento votato al riconoscimento delle mie attività svolte in tanti campi
della cultura e dell’arte, del sociale, come in altri settori dai confini
imprecisati ma sempre rispondenti ai miei sofferti bisogni del pensare e del
fare, dell'amare.
Così
questa lettera mi riempie di sensazioni nuove, a volte molto strane, perché
scriversi, scrivere a se stesso è come scoprire per la prima vota ‘‘il doppio”
del proprio essere, un senso profondo di come in realtà sei fatto.
 |
| da sinistra: Giusto Sucato, Francesco Carbone e Albano Rossi |
Ed
è un compito che non può appartenere a nessun genere di letteratura, non è un
racconto né un diario, ma qualcosa che può comprendere sia l’uno che l’altro,
superandoli subito. Lo ha considerato una volta Tolstoj e anche Roland Barthes
nel Piacere del testo. Ciò nonostante, mi sto scrivendo,
lasciando scorrere nella mia mente e avanti gli occhi una infinità di sequenze
della mia vita legata alle cose che ho fatto e inciso nella memoria in una
evocazione a volte serrata, a volte a rilento, come azionate da una moviola non
elettronica ma magica, in cui il sogno, cioè gli ideali della vita sottendono,
condizionano ogni evento.
Ne
deriva tra l’altro, l’immagine di un intellettuale che tanto si è dato alla
cultura, alle aspirazioni degli altri, alla vita e ai sogni degli altri e molto
poco a se stesso. Eppure questo per me è un pregio, un inestimabile valore,
perché una grande verità è quella di considerare che noi siamo fatti dagli
altri. Gli altri non sono soltanto vicino a noi, ma dentro di noi. Così penso
agli innumerevoli artisti, poeti, scrittori, teatranti, critici, attori e tanti
altri ai quali mi sono dedicato, i quali ho cercato di capire e di aiutare in
tutti questi anni.
Il
maggiore evento per me è quello di non saper fare, di poter fare al riguardo
nessun bilancio: tutto è stato e continua ad essere come in tante aree
imprecisate di straordinaria sospensione, dove nessun codice comune identifichi
la natura degli eventi, il loro spessore reale, la loro entità formale.
Così,
autentici amici affettuosi, con una apposita manifestazione, ora vogliono
ricordare, e ricordarmi, ciò che in questi lunghi anni di molteplici attività,
io ho ideato e realizzato: ne sono infinitamente grato e commosso, e non
dimenticherò per tutta la vita il loro gesto, anche perché questa festa, questo
particolare riconoscimento, avvengono in un momento particolare della mia vita
così provata dalle sofferenze fisiche e psicologiche.
Ma
avviene anche in un momento dei miei sentimenti così profondamente immersi nei
sogni di un affetto e di un amore».
Una
lezione di stile, di passione, di competenza che è anche in tutta l’operatività
creativa e laboriosa di Francesco Carbone, un magistero di libertà e amore che
anche un libro, di cui abbiamo detto, ci dona come memoria viva e che la nuova
Istituzione Culturale a lui dedicata continuamente valorizzerà.
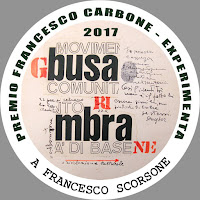


Commenti
Posta un commento